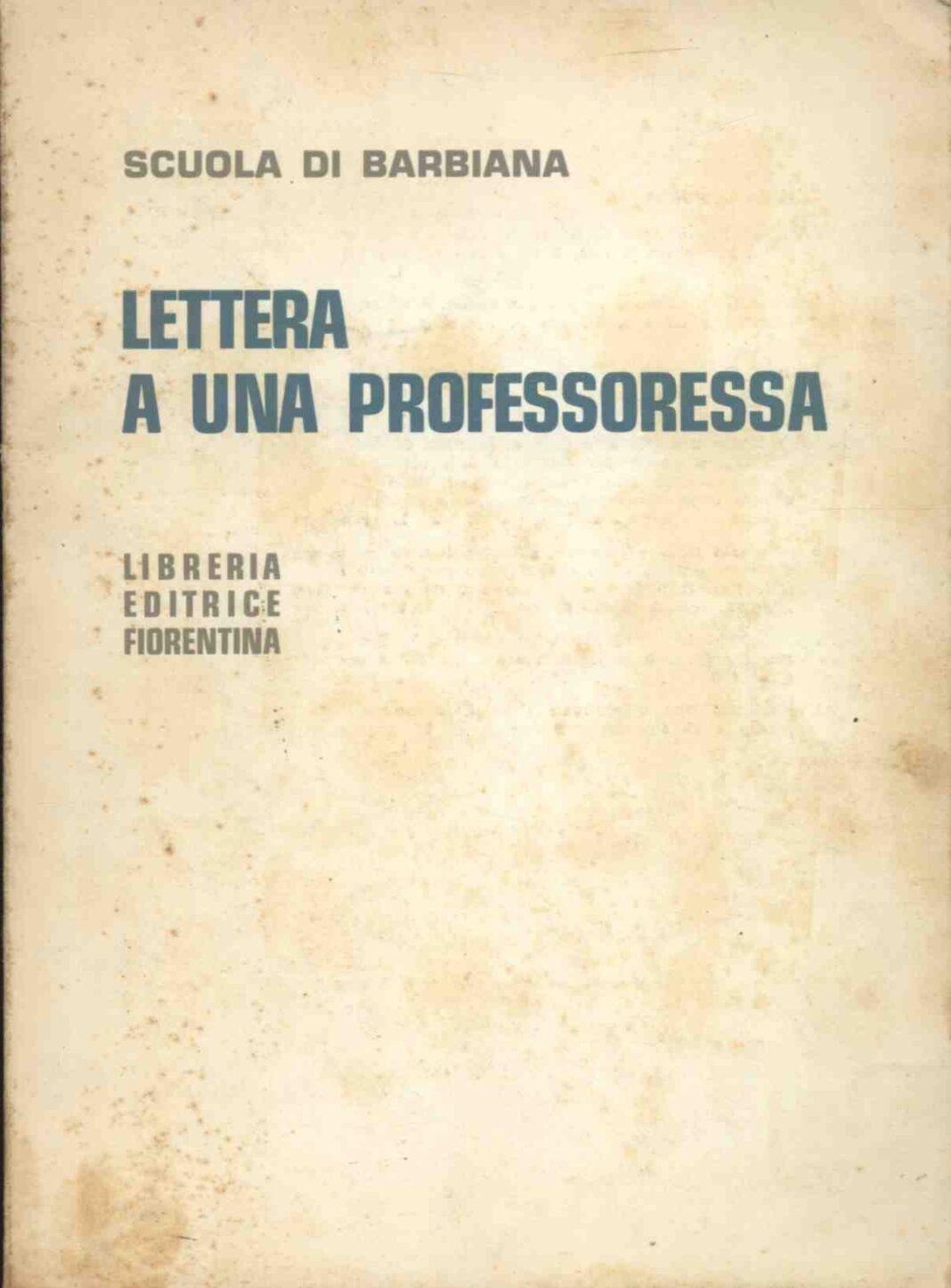Da qualche anno mi capita, per lavoro, di raccontare a ragazzi e ragazze delle scuole medie qualcosa su Alcide De Gasperi. Arriva sempre il punto in cui si parla dell’Impero Austro-Ungarico – lo Stato in cui De Gasperi è nato – e del fatto che in quel contesto l’obbligo scolastico arrivò molto presto. Ci tengo molto a sottolineare che De Gasperi, proprio come loro, passava le sue giornate a scuola nonostante nell’epoca della sua infanzia fosse tutt’altro che scontato che, in altri Paesi, i suoi coetanei facessero altrettanto. A questo punto, c’è la certezza matematica di vedere almeno un paio (spesso molte di più) di testoline pendenti verso il banco tra il sonno e la noia animarsi improvvisamente, e di sentire almeno un paio di commenti come “magari potessimo non andare a scuola!” o variazioni sul tema. Il ruolo che ricopro, oltre a una convinzione personale, mi impone a quel punto di avviare un discorso serieggiante, volto a porre i ragazzi e le ragazze di fronte all’importanza dell’istruzione e alla fortuna che hanno di poterne godere tutti i giorni, senza doversi affaccendare in ulteriori incombenze. Dentro di me, però, mi verrebbe da sorridere di fronte a commenti di quel tipo, sintomo della loro e nostra vera fortuna: quella di non aver mai conosciuto un momento in cui l’accesso all’educazione costituiva un problema o un privilegio da non dare per scontato. Le loro sbuffate sono, in una certa misura, qualcosa di rassicurante, perché come uno specchio ci restituiscono l’immagine di una società, quella italiana, in cui il sistema di istruzione non funzionerà forse in maniera perfetta, ma almeno ha reso lontani i ricordi di bambini e ragazzi lavoratori, ostacolati nell’accesso all’istruzione. Ma quanto lontani?
Nel 1967, cioè appena 56 anni fa, usciva quella Lettera a una professoressa scritta da otto alunni della scuola di Barbiana di Don Milani. Un testo complesso, appuntito e fastidiosamente schietto, che ancora oggi colpisce come colpisce lo sguardo il riflesso del sole sulla carrozzeria di un’auto nuova. Le parole degli studenti autori danno voce a quello che si rivela essere un mondo apparentemente compatto di soggetti esclusi dal sistema di istruzione pubblica e che, rimboccandosi le maniche, di quell’esclusione mettono precisamente a fuoco le cause, i meccanismi, i sadismi e le buone intenzioni che ne sono alla base. I temi trattati e i dati raccolti sono moltissimi, e vanno insieme a creare un’immagine estremamente concreta, che in rilievo porta una constatazione molto semplice ma anche spaventosa: la scuola, denunciano gli autori, non è luogo di democrazia ma, al contrario, luogo di disuguaglianza, dove il contesto di nascita degli alunni conta, così come conta il mestiere dei loro genitori e di conseguenza il loro reddito. Già questa constatazione è di per sé sconcertante ai nostri occhi, ma l’aspetto di questo testo che più di tutti riverbera nel lettore è la concretezza di cui è capace. La scuola è accusata di avere una connessione fin troppo sfibrata con la realtà, oltre che di valorizzare solo i “Pierino”, cioè coloro che già hanno «la cultura in casa», senza però comprendere – anzi, senza voler comprendere nè soddisfare – le esigenze reali dei “Gianni”, figli di operai e portatori di esperienze, background ed esigenze diverse. («Nel suo programma di italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei signora l’ha letto? Non si vergogna? E’ la vita di mezzo milione di famiglie»). La scuola è insomma «un ospedale che cura i sani e respinge i malati», quindi paradossale e senza più un significato.
Di fronte a questa analisi, la scuola di Barbiana si pone come un’alternativa senza però la pretesa di essere perfetta, né quella di diventare un modello da imitare.
Nonostante il tono irruento della Lettera, la risposta attesa e sperata dai suoi autori va nella direzione della ricerca di un confronto con il sistema di istruzione pubblico. In questo senso, nulla esprime meglio l’essenza di questo testo quanto la sua conclusione, costituita proprio dalla lettera di risposta che gli autori si augurerebbero di ricevere e che, nell’attesa, provvedono essi stessi a comporre.
«Ora – scrivono gli otto ragazzi – siamo qui ad aspettare una risposta. Ci sarà bene in qualche istituto magistrale qualcuno che scriverà:
Cari ragazzi,
non tutti i professori sono come quella signora. Non siate razzisti anche voi. Anche se non sono d’accordo su tutto quello che dite, so che la nostra scuola non va. Solo una scuola perfetta può permettersi di rifiutare la gente nuova e le culture diverse. E la scuola perfetta non esiste. Non lo è né la nostra né la vostra. Comunque quelli di voi che vogliono essere maestri venite a dare gli esami quaggiù. Ho un gruppo di colleghi pronti a chiudere due occhi per voi. A pedagogia vi chiederemo solo di Gianni. A italiano di raccontarmi come avete fatto a scrivere questa bella lettera. A latino qualche parola che dice il vostro nonno. A geografia la vita dei contadini inglesi. A storia i motivi per cui i montanari scendono al piano. A scienze ci parlerete dei sormenti e ci direte il nome dell’albero che fa le ciliege (sic)».
Una denuncia schietta, una delicata richiesta di aiuto.
Per approfondire si consiglia la lettura di La scuola buona, a cinquant’anni da Lettera a una professoressa, di Vanessa Roghi, su La scuola buona, a cinquant’anni da Lettera a una professoressa – Vanessa Roghi – Internazionale.