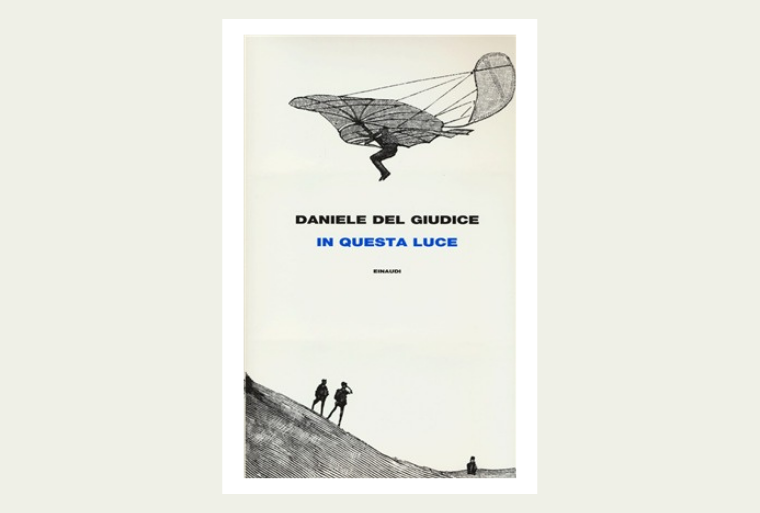A rileggerlo oggi, a 33 anni di distanza dalla sua pubblicazione, oggi che il suo autore Daniele Del Giudice ha definitivamente staccato l’ombra da terra, non si può non cogliere un tono presago nelle pagine di “Nel museo di Reims” (Mondadori, Milano 1988). Emoziona e commuove imbattersi nella descrizione dell’opacità “indistinta e chiara” di cui soffre Barnaba, il protagonista del racconto lungo, e sentirgli ammettere “questa opacità io la sentivo, la soffrivo come un sudore, come una febbre paralizzante, come se fosse non soltanto una malattia degli occhi ma di tutto il corpo; e del resto è per una malattia del corpo, malcurata, che sto diventando cieco”. Lo ha già notato Alessandro Cinquegrani (“Daniele Del Giudice quando ti perdi nel vuoto” su “Doppiozero” il 4 settembre scorso, il giorno dopo la sua morte): ciò può essere considerata la traccia già nitida di un disegno del destino, il prefigurarsi di qualcosa che nel tempo inevitabilmente sarebbe accaduto. Ma consegna anche e soprattutto i temi fondanti nell’opera complessiva del narratore veneziano-romano, delineati nella straordinaria metafora della visibilità del reale, cioè il declinarsi del paradigma che presiedeva alla scrittura dei precedenti “Lo stadio di Wimbledon” (Einaudi, Torino 1983) e “Atlante occidentale” (Einaudi, Torino 1985) e che attraverserà i lavori successivi conferendo loro forma esplicita, “Staccando l’ombra da terra” (Einaudi, 1994), “Mania” (Einaudi, 1997) fino a “Orizzonte mobile (Einaudi, 2009), l’ultimo testo da lui effettivamente elaborato prima di precipitare nel buio: il rapporto di dialettica inquietudine tra l’atto di decifrare il mondo e il gesto di farne scrittura.
Barnaba è un ragazzo italiano che arriva a Reims col l’intento di ammirare il “Marat assassiné” di Jacques-Louis David. Il quadro realizzato nel 1793 espone l’immagine di Jean-Paul Marat immerso nella vasca da bagno con la testa reclinata e l’espressione dolente, eppure cosciente di chi è stato colpito a morte dalle coltellate di Charlotte Corday e sta per spirare. Lui sa che esistono almeno cinque versioni del dipinto, due davvero attribuibili a David – conservate a Bruxelles e appunto a Reims – , una replica che si trova a Versailles e altri due esemplari indicati come copie: conosce il particolare che distingue il “Marat” di Reims da quello di Bruxelles, quella dedica che non si limita all’intestazione “A Marat, David” ma che aggiunge la frase più complessa: “N’ayant pu me corrompre ils m’ont assassinè”: “Quasi che il movente del delitto dovesse essere stampato nei pressi del cadavere”, spiega Del Giudice. Esattamente la rivelazione che Barnaba vuole cogliere, la dicitura per la quale si è mosso fino al Museo di Reims, la curiosità che lo ha portato lì anche se è consapevole di non poterla catturare con lo sguardo perché la malattia lo sta facendo diventare completamente cieco.
Si affida allora alla compagnia di Anne. Sarà lei a descrivergli ogni immagine e qualsiasi dettaglio. Perché gli interessa proprio quel quadro?, chiede. Barnaba è stato un ufficiale di Marina, dunque educato alla precisione dei messaggi a chi guida le navi nelle tempeste che Joseph Conrad – l’autore di “Cuore di tenebra, “Nostromo” e “Tifone” – ha dettagliato nel piccolo e prezioso saggio dal titolo “Fuori dalla letteratura” che ha come argomento giusto gli avvisi ai naviganti: per Daniele Del Giudice il manifesto insuperato della responsabilità etica nella scrittura. La risposta ad Anna è “mi interessa perché mi sono sempre chiesto che cosa pensa un medico nel momento in cui muore. Marat, prima di essere Marat, era un medico, e un fisico”. Un medico che “curava i ciechi. Li curava con l’elettroterapia. Con una certa dieta, delle pomate e delle piccole scariche elettriche”.
Sa che quel quadro lo riguarda, insomma. Ha studiato le tappe della ricerca di Marat, i suoi esperimenti, i casi di “Una singolare malattia degli occhi” senza nutrire speranze per sé bensì per indagarne gli aspetti, approfondire i trattati di ottica, ammirare la costruzione dei filtri a serpentina, registrare le polemiche con Isaac Newton e l’ammirazione riscossa da Johann Wolfgang von Goethe, gli incontri con Benjamin Franklin, le analisi sulla scomposizione dei colori, il giallo, il rosso e il blu, “tutte cose che io già vedevo poco e non avrei visto più, forse per questo mi appassionava così tanto”. Lo comunica ad Anne, la quale ne è stupita e continua a svolgere il suo compito spesso sviando nel vizio – la mania? – da cui non si separa: la bugia, la menzogna, l’approssimazione. “Riesce a vedere quello che c’è scritto sulla cassetta di legno?”, lo interroga davanti al quadro. E Barnaba: “A Marat, David”. Sorride e pensa intensamente alla scritta in nero “N’ayant pu me corrompre ils m’ont assassinè”. “La pensò sillaba per sillaba, con tale forza che quasi riuscì a vederla tutta intera”, annota Del Giudice. Però il ragazzo dice sorridendo ad Anne: “C’è scritto solo “A Marat, David”. Sta al suo gioco. Anne chiude il brano: “Sì, soltanto due parole”, con una voce che “aveva un colore caldo e brillante, lucido di tenerezza”.
“Nel museo di Reims” compare in un volumetto composto anche da sedici illustrazioni di opere di Marco Nero Rotelli, l’artista nei cui spazi sui Navigli a Milano prima e in Campo San Giacomo dell’Orio dopo Daniele Del Giudice ha respirato l’odore dei colori e guadagnato il tipo di luce che filtra dalle vetrate. Ne è conquistato. “Mi piace questo spettacolare equilibrio che lui riesce a trovare tra ordine e invenzione, tra il limite formale che si dà e il modo inaspettato in cui lo buca, tra la temperatura calda dei colori in cui si abbandona e il rigore leggero con cui riprende il quadro e lo chiude, oppure lo lascia sorprendentemente aperto”, confessa. Rotelli da parte sua commenta: “La scrittura può portare in un luogo e così la pittura. Nel caso mio e di Del Giudice la vicinanza è più in quel luogo che non nel percorso che si segue per raggiungerlo”.
Nelle sedici opere si percepisce una sottile e nitida geometria della luce che segna le sfumature sulla tela quasi tagliandola, conferendole un effetto di profondità verticale. “Sarebbe bello se anche nelle storie scritte si potesse parlare così, dall’interno, senza correre ai significati, che molto spesso non ci sono”, aggiunge Daniele Del Giudice e così dichiara che cosa ci sia alla base del suo testo: “Solo un pacco di fotografie di quadri non troppo messe a fuoco e in bianco e nero ricevute da quel museo un po’ di tempo fa, una piccola scoperta incidentale in un volume di storia della medicina mentre finivo di scrivere il racconto, e una mia personale esperienza di bugie”.
Il libro esce nel 1988. E’ l’anno di pubblicazione delle “Lezioni americane” di Italo Calvino, le sei lezioni programmate all’Università di Harvard in vista del ciclo accademico 1985-1986 purtroppo rimaste incompiute per la morte sopraggiunta il 19 settembre 1985. Qualche anno prima – nel 1983 – Calvino fa dire al suo dubbioso Palomar che “bisogna ristudiare tutto da capo” e nello scarto tra l’espressione linguistica e l’esperienza sensibile pare ritrovare la sentenza di Ludwig Wittgenstein sul senso comune, definito come il luogo in cui si distingue il vero dal falso. Su ciò di cui non si può parlare occorre tacere e Palomar lo ha ben compreso, magari grazie alla lezione di Francis Ponge, quando annuncia la vittoria della realtà concreta sulle supposizioni argomentate. Torna utile ricordare quanto nella raccolta delle conferenze per l’ateneo statunitense si legge a proposito della tema della visibilità: “Se ho incluso la “Visibilità” nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il poter mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini”. Viene evocata la capacità della scrittura, l’ambito nel quale “tutte le realtà e le fantasie possono prendere forma”, dove “esteriorità e interiorità, mondo e io, esperienza e fantasia appaiono composte della stessa materia verbale”, la pratica che riesce a esprimere e contenere in segni allineati “come granelli di sabbia”, caratteri, punti, virgole e parentesi “le visioni polimorfe degli occhi e dell’anima”.
Basta questo per attribuire a Daniele Del Giudice lo zodiaco calviniano? L’autore del “Museo di Reims” chiarisce, appena uscito il libro, che “in verità quello che sentivo vicino di Calvino non è la lettera del suo lavoro, ma lo spirito del suo lavoro. Il modo di essere di fronte a questo mestiere”. Una opzione di metodo, la postura che fa scaturire un procedimento al quale Del Giudice intende comunque alzare la temperatura emotiva, misurandosi con i temi dell’amore, del dolore, dell’enigma della vita per sfuggire alla tentazione della descrizione minuziosa e precisa dei meccanismi di funzionamento alla maniera della scuola dello sguardo del “Nouveau roman”. Sperimentando, di converso, un linguaggio per poter almeno bordeggiare la verità, se non per dirla tout cout.
Nel fatidico 1988 è Gianni Celati – uno dei due autori a cui Alberto Asor Rosa assegna l’oroscopo calviniano, l’altro è Del Giudice – in un articolo su “Il Manifesto” ad accendere la spia dell’allarme. L’arte del narrare è giunta al tracollo – argomenta ne “L’angelo del racconto”, titolo di evidente suggestione benjaminiana- , sopraffatta e annichilita da quella che definisce “una nuova figura paranoide”: “Lo spiegatore a oltranza”. Questo tipo di narratore utilizza le lingue standard moderne le quali altro non sono che “architetture di frasi fatte (quelle che leggiamo ogni mattina sul giornale) e le frasi fatte non possono dire la verità. Loro scopo, infatti, non è di svelare, bensì di dare per scontato uno stato di cose”. Avvilisce le narrazioni che al contrario servono a “immaginare come è fatto il mondo attraverso un buon ascolto delle parole”.
Nel 1985 un fotografo ha pensato di dover scardinare il fronte della paranoia esplicativa: si tratta di Luigi Ghirri che con “Esplorazioni sulla via Emilia” raccoglie le sue “Vedute nel paesaggio”, dove il “nel” invece di “del” contiene gran parte della sua poetica. Nel 1989, Ghirri assieme a Celati esplorerà quel tratto di territorio su cui la modernità ha impresso il suo marchio avvilente e “Verso la foce” diventerà il documento di uno spaesamento che ha mescolato le anime, il diario di un viaggio lungo il Po che nella tarda serata del 3 giugno 1983 si chiude con la preghiera laica: “Ogni fenomeno è in sé sereno. Chiama le cose perché restino con te fino all’ultimo”. Ridare un nome al mondo, liberarsi dall’inganno della falsa evidenza e della realtà interpretata. Abbandonarsi all’aperto dell’Ottava elegia duinese di Rainer Maria Rilke, all’apparenza e all’immaginazione. “E’ la nostra via d’accesso a ciò che chiamiamo mondo, ossia tutto l’insieme degli eventi e dei fenomeni e stati di cose che per noi (umani) hanno senso e sono esprimibili con le parole”.
“Quattro novelle sulle apparenze” di Gianni Celati arriva nel 1987. Recensendo “Nel Museo di Reims” sul “Corriere della sera”, Antonio Tabucchi confessa che “questa è una novella sulle apprenze, mi sono detto, e mi sono venuti in mente i racconti di Gianni Celati; e ho pensato anche che se qualcuno vuole davvero approfondire il discorso su certa letteratura italiana deve cominciare a domandarsi perché e come si scrive sulle apparenze, e quali sono queste apparenze e i fantasmi che le percorrono”. L’autore di “Piccoli equivoci senza importanza” del 1985 e de “Le regole dell’orizzonte” del 1986 sa che soltanto oltre le apparenze dimorano i significati. Ha letto il brano in cui Barnaba dichiara “è da quando ho saputo che sarei diventato cieco che ho cominciato ad amare la pittura”. Nel 1983, nella splendida e introduzione ai “Diari (1927-1961)” di Antonio Delfini, Cesare Garboli aveva compreso che “leggere è vedere, e scrivere è essere ciechi”. Perché la verità che si rovescia nella menzogna davanti al “Marat assassiné” di David altro non è che la consacrazione di una ulteriore verità. Tabucchi la chiama “la verità della finzione”. La scrittura.