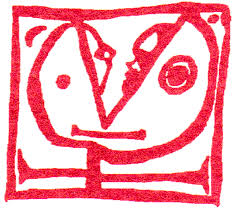Non è tanto dell’aiuto degli amici
che noi abbiamo bisogno, quanto della fiducia
che al bisogno
ce ne potremo servire.
[Epicuro, Sentenze e frammenti]
Come legare ciò che slega? Come connettere il tempo dello s-radicamento con l’esperienza di un sentire collettivo? A partire dall’esperienza degli operatori di una équipe della salute mentale e dalle testimonianze di soggetti direttamente coinvolti dal Covid, siamo passati dalle parole alle passioni, dalle parole alle emozioni. Per tornare alle parole, trovando quelle ‘giuste’, per rispondere alla domanda che ci siamo posti: “Che cosa ci è successo?” 1
CHE COSA CI È SUCCESSO? RACCONTO DELL’ATTRAVERSAMENTO
Il lungo periodo che abbiamo attraversato convivendo con la pandemia non ci permette di continuare a parlarne in termini di un ‘evento’. Non più. Abbiamo bisogno di trovare una nuova parola per descrivere questa co-abitazione forzata con la paura e l’incertezza. Un evento si definisce tale in quanto crea una rottura tra un prima e un dopo: se del prima abbiamo ancora nostalgia (qualcuno ne ha?), sul dopo non siamo certi di avere una chiara visione. Questo ‘attraversamento’ appare ancora in corso. E il dopo non si profila all’orizzonte. Qualche visione filmica o letteraria ci permette di intuire questo dopo. Nel gruppo di lavoro del quale faccio parte, un anno fa (ormai) abbiamo cominciato ad interrogarci su quanto ci stava succedendo. Perché quanto stava avvenendo appunto ci riguardava, esattamente come riguardava i pazienti che non potevamo incontrare in presenza, ai quali consigliavamo di stare a casa, di non venire al servizio tantomeno di andare al PS per una urgenza. Evento, urgenza. La lista di parole inadatte a descrivere quello che stava e sta accadendo si allunga. Da quelle riflessioni, del nostro gruppo di operatori di un servizio di salute mentale della città, nascono questi appunti. Di un evento che non passa, di una urgenza che continua a tagliare il respiro. Di un dopo che è, inevitabilmente, ora.
UMANI SENZA TRAUMA
Francesco Stoppa scrive: “nulla è più traumatizzante di una società detraumatizzata” (La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, ed. Feltrinelli, 2011, pag. 15). Questa riflessione è presente nelle prime pagine del libro e, riletta oggi, pare anticipare il tempo della pandemia e di quanto ci è successo. Stoppa si riferisce all’accompagnamento iperprotettivo e ipertrofico degli adulti nei confronti del bambino; una comunità di umani, che sembra agitarsi per evitare qualsiasi tipo di trauma, di caduta ai propri bambini. Ma un bambino detraumatizzato, scrive ancora Stoppa, “è un bambino senza infanzia, senza ricordi di cadute, graffi, ferite, situazioni o luoghi tanto paurosi quanto seducenti” (pag. 14). Senza trauma non entriamo in quel terreno che ci rende umani, che costruisce la nostra soggettività e il nostro ingresso nella civiltà, nel mondo della co-abitazione, della convivenza e del dialogo intergenerazionale. Il trauma collettivo che la pandemia ci ha fatto vivere appare, paradossalmente, un’esperienza di costruzione di un umano che possa dirsi e darsi nella testimonianza di una vulnerabilità generalizzata e di una solidarietà non scontata, bensì scelta. Questa mi sembra rappresentare la parte difficile e, speriamo, duratura dell’attraversamento in corso.
Il terreno sotto i nostri piedi era già franoso, instabile, inospitale ben prima della pandemia. Eravamo su un terreno sabbioso e pensavamo, titanicamente, di essere su una roccia, su un Olimpo inespugnabile. Eppure…Eravamo, siamo, ‘uomini di sabbia’. L’uomo di sabbia è il titolo di un bel libro di Catherine Ternynck (ed. Vita e pensiero, 2012) che descrive l’esperienza contemporanea dell’umano senza humus, gli “esemplari di uno strano genere, mal piantati sulle loro basi, oscillanti, tormentate” (pag. 9). Questi ‘esemplari’ siamo noi: ieri e ancora di più oggi. La Ternynck sembra intuire quanto ci manca il nutrimento necessario per costruire un umano capace di accettare il passare delle età, capace di accogliere le differenze e il molteplice, aperto al mondo immateriale ed invisibile quanto a quello concreto (per non rischiare di trasformarci tutti in consumatori di cose, personalità ‘normotiche’ direbbe Bollas, disinteressate alle emozioni e alla soggettività). In questa condizione il mondo sembra trasformarsi in una natura ostile, rivale, pericolosa. “Il suolo umano si era impoverito, era diventato anemico, friabile, inconsistente. Mancava sotto i piedi. Il suolo umano stava perdendo il suo humus. Virava alla sabbia. Stavamo diventando uomini di sabbia” (pag. 9). Umani che franano come il terreno stesso dove posano i passi.
COLLETTIVO SENTIRE
L’esperienza della pandemia ci ha riconsegnato un sentire collettivo. La paura, l’incertezza, l’insicurezza sono le emozioni (le passioni) che si sono radicate nel nostro corpo e insediate nelle nostre menti. Le risposte soggettive, registrate tra i colleghi del servizio nelle riunioni del mattino, o raccolte nelle parole a distanza all’inizio e poi di nuovo in presenza dei pazienti, o nelle interviste-testimonianze a persone direttamente colpite dal Covid, sono state momenti di ‘insight collettivo’ nel tempo traumatizzante dalla pandemia. Tra questi momenti di insight comprendo l’attesa paziente e l’esperienza di un comune sentire. I servizi hanno attraversato un tempo ‘senza’ pazienti e i pazienti un tempo ‘senza’ servizi, in un rispecchiamento reciproco che ha consegnato una attesa piena, un tempo di fiducia capace di andare oltre, al di là della distanza fisica. Una frase banale e usurata come “ti sento”, si è colorata in questo lungo anno di una nuova consistenza. Nella distanza, nella separazione forzata, nell’isolamento coatto, ci si sentiva. Una esperienza collettiva di presenza nell’assenza, un tempo di sospensione, di pausa che ha permesso quella identificazione immediata, fraterna, solidale. Necessaria.
“Con l’arrivo della Morte Scarlatta il mondo è andato in pezzi, nel modo più assoluto e irrimediabile. Diecimila anni di cultura e civiltà svaniti in un batter d’occhio, fugaci come schiuma”2. Così scrive Jack London nel lontano 1912, profetizzando di una epidemia (l’influenza spagnola) che si sarebbe abbattuta sul genere umano nel 2013; vi si parla di una malattia, la peste scarlatta, che non lascia scampo. Eppure, qualcuno resiste: un vecchio e i ‘suoi’ nipoti selvaggi. Intorno ad un fuoco il vecchio racconta di come l’umanità, con il pretesto della morte invincibile, si sia autorizzata a compiere azioni di brutale e perversa crudeltà durante la pandemia. Una narrazione, quella di London, capace di ricordarci il debito verso il vivente, il pianeta e le forme di vita, la responsabilità verso il futuro che rischia di svanire, “in un batter d’occhio”.